eBook Gratuito, Voce AI, Audiolibro: Storia degli Italiani, vol. 03 (di 15) di Cesare Cantù
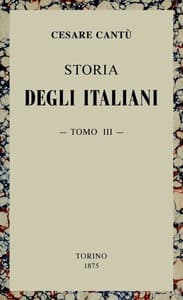
Audiolibro: Storia degli Italiani, vol. 03 (di 15) di Cesare Cantù
0:00 / Unknown
Loading QR code...
Puoi ascoltare il contenuto completo di Storia degli Italiani, vol. 03 (di 15) di Cesare Cantù nella nostra app AI Voice AudioBook su iOS e Android. Puoi clonare qualsiasi voce e creare i tuoi audiolibri da eBook o siti web. Scarica ora dall'App Store mobile.
Ascolta l'Audiolibro: Storia degli Italiani, vol. 03 (di 15) di Cesare Cantù
CAPITOLO XXXI.
Il secolo d'oro della letteratura latina.
Un'altra fortuna ebbe Augusto, che al suo corrispondesse il secolo d'oro della letteratura latina, talchè il nome di lui, non solo si associò all'immortalità di quegli scrittori, ma rimase come appellativo de' protettori del bel sapere.
Ne' primordj, Roma s'occupò a difendersi e trionfare, non ad ingentilire gl'intelletti. Sol quando penetrò nella Grecia italica, poi nella Grecia propria, conobbe una coltura più raffinata, e la introdusse coi prigionieri e coi vinti, i quali allogaronsi come maestri o clienti nelle principali famiglie; e tal ne prese vaghezza che dimenticò i modi nazionali per tenersi affatto sulle orme greche. Quand'anche non fosse natura degl'Italiani, sappiamo per iscritto che il popolo nostro dilettavasi grandemente di canzoni nelle varie fasi della vita; specialmente alle vendemmie, e quando la riposta messe lusingava terminate le fatiche, e alle solennità della rustica Pale i prischi agricoli, forti e contenti di poco, coi figli, colla fedele consorte e coi compagni di lavoro esilaravano l'anima e il corpo nel suono e nel ballo; e la gioja bacchica esultava in canti e gesticolazioni, e forse anche dialoghi, di versi regolati dall'orecchio e misurati dalla battuta del piede.
Questa fu per gran pezzo l'unica drammatica, ben lontana dalla artistica che pur già grandeggiava in Sicilia, e che richiede un'azione, un intreccio, e caratteri e affetti. Abbiamo notizia di recite che si facevano in siffatti versi, chiamati saturnini dal favoloso Saturno, o fescennini da Fescennia, città dove molto erano usati alle Sature, mescolanza di musica, recita e danza. Inconditi e mal composti, smentiscono però Orazio quando di letteratura romana non trova lampo se non dopo l'occupazione della Grecia; più lo smentisce la storia. Tito Livio, in un passo d'oro, fa che i Romani desumano anche i giuochi scenici dagli Etruschi, dicendo che nell'epidemia del 390 di Roma, la collera celeste serbandosi inesorabile alle supplicazioni consuete, si introdussero (cosa nuova al popolo bellicoso, avvezzo soltanto agli spettacoli del circo) rappresentazioni sceniche, fatte da commedianti etruschi che nella costoro lingua chiamavansi istrioni, i quali ballavano artifiziosamente a suon di flauto e gestendo senza parole: i garzoni romani gl'imitarono, aggiungendo versi rozzi ma lepidi: in appresso s'introdussero buoni istrioni che ne recitarono di studiati, e rappresentarono satire, le cui parole convenivano al suono del flauto e al movimento. Livio Andronico (segue egli), più d'un secolo dopo, osò far meglio, e comporre drammi con unità d'azione; e avendo perduto la voce, ottenne di collocare davanti all'attore un giovane che cantava i suoi versi, mentr'esso faceva i gesti, viepiù espressivi perchè non era distratto dalla cura della voce. Di qui l'uso agli istrioni di accompagnare col gesto ciò che un altro canta, non parlando essi che nel dialogo.
Adunque Livio Andronico introdusse la favola teatrale, che soggetti forestieri riproduceva in favella barbara, cioè nella nostra. Al solo ritmo, consueto nei carmi latini ed osci, sostituì il senario, libero verso, che traeva dall'accompagnamento della tibia quel tenor regolare e cadenzato che nella sua libertà gli mancava, e che formò passaggio fra la ritmica indigena e la metrica esotica. A quel modo continuarono e Nevio e Plauto, sempre scusandosi di tradurre i Greci in barbaro, cioè nel parlare di que' Romani, che per chiamare poi barbari gli altri popoli dovettero persuadersi d'essere divenuti Greci.
Ennio diede un passo innanzi, e abbandonando il pedestre senario, introdusse l'eroico greco: laonde si dava vanto d'aver «superato egli primo i monti delle muse, mentre fin a lui erasi detto soltanto coi versi che cantavano i fauni e i vati», cioè gl'indigeni: introdusse il dattilo e il verso esametro, la cui musicalità era accessibile del pari ai dotti e al vulgo.
Andronico, Ennio, Plauto, Azzio, Nevio trattarono soltanto soggetti greci, benchè in Grecia non fossero ancora penetrati i Romani, non avessero «cercato le bellezze di Tespi, Eschilo, Sofocle», nè Mummio avesse recato gli spettacoli teatrali da Corinto: laonde possiamo credere che quest'arte derivasse piuttosto dalla Sicilia, dove Aristotele e Solino la fanno nascere, e trasportare in Atene da Epicarmo e Formione; ovvero dalla Magna Grecia, ove molti Pitagorici aveano scritto commedie.
Di tre parti constava la commedia: diverbio, cantico, coro. Pel primo intendesi l'atteggiare di più persone: nel cantico parlava una sola, o se ve n'era un'altra, udiva di nascosto e parlava da sè: nel coro era indefinito il numero de' personaggi. Molta varietà v'ebbe poi di commedie: le gravi diceansi palliatæ o togatæ, secondo che di soggetto greco o romano; nelle prætextatæ s'introducevano persone di grand'affare, vestite della pretesta; inferiori erano le tabernariæ e i mimi.
Dal succitato passo di Livio i teatri romani compajono non semplice passatempo, ma un'istituzione civile e sacerdotale, e la recita come un'appendice di quelli che i romani tenevano per veri divertimenti, i giuochi del circo. Inoltre gli scrittori di commedie non erano romani, ma Ennio di Calabria, Pacuvio di Brindisi, Plauto di Sarsina nell'Umbria, Terenzio di Cartagine; talmente convenzionale era il linguaggio di quelle. Il romano popolesco rimase alle atellanæ, che alcuno vorrebbe somigliare alle nostre commedie a soggetto: recitavansi in osco da giovani bennati, e allettavano grandemente il popolo per lo scherzo vivace e per l'originalità.
Diciannove tragedie di Marco Pacuvio sono lodate da Quintiliano per profondità di sentenze, nerbo di stile, varietà di caratteri; ma nel pochissimo rimastoci non troviamo che liberissime imitazioni, in istile bujo e disarmonico. Lucio Azzio, nato a Roma da un liberto, ne compose e raffazzonò di molte, fra le quali il Bruto e il Decio, soggetti patrj; e recitavansi ancora ai tempi di Cicerone, e più volentieri si leggev
Puoi scaricare, leggere online, trovare maggiori dettagli di questo eBook completo Storia degli Italiani, vol. 03 (di 15) di Cesare Cantù da
E convertilo nell'Audiolibro con qualsiasi voce desideri nella nostra app AI Voice AudioBook.
Loading QR code...




